|
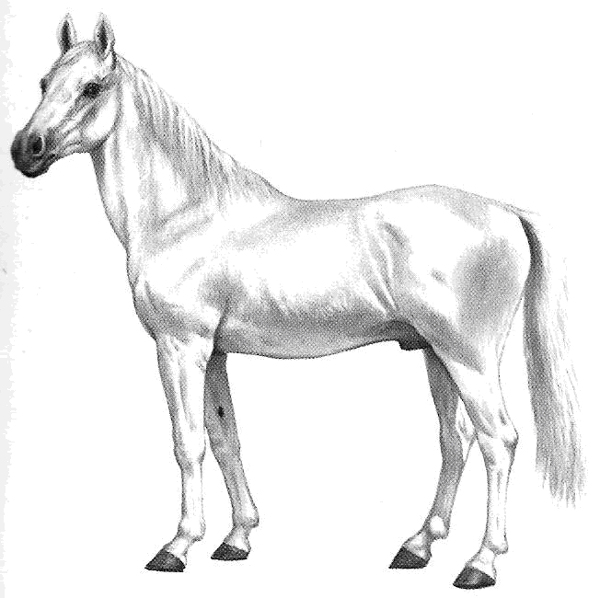
A
maggio, quando morì la vecchia Gisella, giunta dalla
città, si stabilì in paese la sua giovane nipote,
Romilda. Firmò gli atti dal notaio, parlò con il
podestà (1) e poi si trasferì nella bella casa di
Gisella, sul bricco (2) più alto, che a guardarlo dal
paese spicca verdissimo sullo sfondo delle montagne. Romilda era molto
bella, alta, slanciata, bionda con i lunghi capelli sempre raccolti in
trecce e gli occhi di un azzurro profondo. Presto la casa riprese a
vivere: il giardino curato, l’orto ordinato, le rose fiorite a
far cornice al cancelletto d’ingresso, tutto stava a dimostrare
che Romilda era una ragazza buona e coscienziosa. Aveva talmente tante
doti che presto i giovanotti del paese cominciarono a ronzare attorno
alla casa di Gisella come api attorno ad un fiore. Ma Romilda, cortese
ed educata con tutti, non dava spago a nessuno né era solita
fare la smorfiosa. In paese tutti apprezzavano il suo comportamento ed
era benvoluta.
Nel mese di settembre Stefano, il figlio del farmacista, finì il
servizio militare. Con la sua uniforme di panno blu, il kepì in
testa, le buffetterie bianche (3) e lo zaino a spalla tornava al
paese. Era notte ma la luna piena illuminava i prati. Stefano era
felice: tra poco sarebbe stato di nuova a casa sua, tra la sua gente.
D’un tratto sul versante della collina vide un cavallo bianco al
galoppo, la criniera al vento e la coda alta, diritta e fiera. Stefano
si ferma come abbagliato dalla visione e il cavallo, ora distante da
lui solo una ventina di metri, si inchioda sulle quattro zampe, lo
osserva a sua volta, nitrisce, si volta e galoppa scomparendo lontano.
Stefano pensa: “Che cavallo meraviglioso. Devo sapere chi
è il padrone e convincerlo a vendermelo!”. E sospirando si
avviò verso casa. Fu grande festa nella casa del
farmacista ma a Stefano la curiosità arrovellava il cervello.
“Padre, di chi sono i prati sulla collina?” “Vuoi
dire il bricco di Gisella? Dalla sua morte sono della nipote,
Romilda”. La mattina dopo, quando l’ora parve decente,
Stefano si diresse alla casa di Romilda. “Signorina voi possedete
un cavallo bianco che la notte galoppa nei prati?”. “No
caro signore. Non posseggo altri animali che il mio gattino (4) ,
quello nero che vedete nascondersi lassù sul fienile”. Ma
qualcosa scattò nella mente e nel cuore dei due giovani, che,
con gli occhi persi negli occhi, presto dimenticarono i cavalli e notti
di luna piena. Fu solo il campanile che rintocco il mezzodì a
farli tornare su questa terra. Stefano imbarazzato salutò
scusandosi dell’incomodo, Romilda abbassò pudicamente gli
occhi, arrossendo. Fatti quattro passi verso il borgo Stefano
trovò il coraggio, vi volto e chiese “Signorina Romilda,
posso tornare a trovarvi qualche volta?”. Romilda annuì e
corse in casa con il cuore che batteva all’impazzata. Le visite
di protrassero, con sempre maggiore frequenza, per tutto
l’autunno e l’inverno fino a marzo quando Stefano decise di
parlare al padre per avere l’autorizzazione di chiedere Romilda
in sposa (5) . A dire la verità tanto il farmacista quanto tutti
gli altri paesani si domandavano quanto avrebbero ancora atteso i due
innamorati a convolare a giuste nozze. Era uno splendido mese di maggio
quando si celebrò il matrimonio, sembrava che le rose ed i fiori
dei giardini del piccolo borgo avessero atteso un evento eccezionale
per dare sfogo a tutta la loro bellezza. Stefano e Romilda stabilirono
nella casa di Gisella il loro domicilio coniugale e lì
iniziarono a vivere una storia d‘amore di quelle che solo sui
libri sembrano esistere. Era giunto luglio quando nel cuore della notte
Stefano si svegliò con una strana sensazione. Romilda non era
nel letto accanto a lui. In preda ad un’improvvisa agitazione
Stefano balzò dal letto: in un attimo fu nel giardino ma di
Romilda nessuna traccia. Il cancelletto tra le rose era aperto. Corse
fuori e di qui verso il borgo. Non c’era pericolo di inciampare
con quella luna piena… Come folgorato andò ai prati e
lì galoppava il cavallo bianco. Stefano si nascose dietro un
folto cespuglio e quando il cavallo fu lì vicino balzò
dal suo nascondiglio e lo abbraccio al collo. Per un attimo si
trovarono, uomo ed animale, con gli occhi negli occhi: quelli del
cavallo erano di un azzurro profondo! Per la sorpresa Stefano
mollò la presa ed il cavallo, via di corsa, sparì dietro
il crinale. Un dubbio si insinuava nel cervello di Stefano: dalle valli
fino alla Langa (6), in tutto il cuneese si sa che certe donne hanno il
dono, o la maledizione, di trasformarsi in animali. “Ho sposato
una masca (7) , sarò forse per questo dannato in eterno?”
che erano ancora recenti le memorie di roghi e inquisitori (8) . Deciso
a fare luce sulla questione ritornò a casa ma
nell’attraversare il giardino il gatto nero di Romilda gli
finì tra i piedi facendolo ruzzolare a terra. “Contacc (9)
al gatto!” Si rialza un po’ indolenzito, controlla che
nulla sia sgusciato dalle tasche, si accerta che il gatto non abbia
riportato danni (ma si è mai visto un gatto che si faccia male
quando fa una marminella (10) ?) e rientra in camera da letto
massaggiandosi un gomito. Romilda è in piedi accanto al letto,
trafelata, con i capelli sciolti sulle spalle. “Stefano cosa
è accaduto che ti sei precipitato fuori casa nel cuore della
notte? Ti ho sentito dalla cucina dove ero andata a bere un sorso
d’acqua e mi sono preoccupata. Quando poi ho sentito quel gran
baccano in giardino ho pensato che dei birbanti ti fossero saltati
addosso e solo ora che ti vedo sano e salvo mi riprendo un poco dallo
spavento. Ma ti prego, raccontami.” Tra se Stefano pensò
“…e che cosa le racconto, che sono un salame, uno che vede
cavalli con gli occhi azzurri e dubita della propria moglie, uno che
invece di ringraziare Dio per il dono dell’amore di Romilda si
immagina magia e fisica sotto il proprio tetto. No le racconto la
verità”. “Mi sono svegliato e non ti trovata accanto
a me. Forse ero ancora un po’ addormentato sono uscito di casa ma
il sogno mi ha seguito e ho rivisto quel magnifico cavallo. Sono
tornato a casa e non ho visto il micio nero, l’ho travolto e sono
caduto. No, nessun problema: il micio sta benissimo. Ed io sono felice
di essere di nuovo accanto a te!”.
La storia ci dice che di cavalli nelle notti di luna piena sul bricco
di Gisella non se ne sono visti più, che dopo l’inverno,
in aprile quella casa fu allietata dall’arrivo di una splendida
bambina con i capelli biondi, che il gatto nero prese immediatamente a
balia, presidiandone giorno e notte la culla. Di figli ne arrivarono
ancora altri cinque ma quella prima bambina fu davvero speciale. Ma
questa è tutta un’altra storia.
(1) Capo del comune medioevale che rendeva giustizia e guidava l’esercito in guerra.
(2) La cima aguzza di una collina. Zingarelli ritiene sia un
termine di radice preindoeuropea, cioè che risale a culture
precedenti quella latina.
| (3) Queste sono le caratteristiche delle divise militari
ottocentesche. La giacca è corta con due file di bottoni di
metallo lucido che la chiudono fin sotto il collo, il colletto con le
mostrine, il kepì è un cappello cilindrico alto 10- 15 cm
con visiera di tela cerata e sottogola, le buffetterie sono il
cinturone a cui è appesa la sciabola (sabro) o la baionetta
(corta sciabola che si monta sulla canna del fucile), la giberna in cui
vengono custodite le cartucce, ed infine le due bandoliere incrociate
che passando sulle spalle sorreggono il cinturone. |
 |
(4) Il gatto nero è un simbolo di una magia a
volte solo misteriosa, a volte perversa. È l’animale
imperscrutabile, autosufficiente che decide con chi e per quanto tempo
accompagnarsi; mai ha un padrone,se mai un ospite. Di notte i suoi
occhi gialli fiammeggiano nell’oscurità quasi a ricordare
le fiamme dell’inferno dei dannati. Tanto bastava per intessere
attorno al povero micio tutta una pletora di leggende e storie
spaventose.
(5) Il capofamiglia fino a pochi anni fa doveva decidere per il
bene di tutto il nucleo familiare. Le scelte sulla possibilità
di fare delle spese o assumersi responsabilità nei confronti di
terzi era una sua competenza esclusiva che nessuno metteva in dubbio:
erano tempi in cui era duro mettere assieme il pranzo con la cena e
quindi ne andava della sopravvivenza dell’intera famiglia. Ovvio
che una decisione importante come un matrimonio dipendesse dal
capofamiglia.
(6) Dalle nostre valli per raggiungere la Langa bisogna scendere
a valle, attraversare la pianura alluvionale e risalire su quelle
colline. Per chi viveva sulla montagna cuneese dire dalle valli alla
Langa equivaleva a dire: da una parte all’altra del mondo
conosciuto.
(7) Masca è il piemontese sinonimo di strega ma il termine
italiano è riduttivo. Masca è anche l’essere umano
che si trasforma in bestia, chi sa parlare con i morti, chi legge gli
avvenimenti negli oggetti, chi predice il futuro, chi lancia
maledizioni oppure ve ne libera. Masca è tutto quello che
è magico, inspiegabile, ad di là dell’umana
comprensione. In secoli dove scienza e cultura erano poca cosa e in
più patrimonio di pochissimi, di cose inspiegabili dovevano
essercene moltissime e quindi moltissime erano le forme di stregoneria
e di magia che intessevano la cultura e la vita di quei nostri
antenati.
(8) Dopo il Concilio di Trento (1563) e fin oltre la metà
del ‘600 l’Inquisizione, per reazione alla riforma
luterana, attuò una capillare azione di identificazione
dell’eresia in ogni sua forma. Ne patirono scienziati, filosofi,
protestanti ed ebrei, ma anche uomini e donne semplici, per qualche
motivo oggetto di pubbliche denunce. Così toccò ai
deformi e agli storpi di finire sul rogo, e soprattutto alle
indemoniate, alle figlie di Satana, alle streghe. A questa vergogna
storica non si sottrasse il Piemonte: ancora nella prima metà
del secolo qualche poveretta finì bruciata per presunte pratiche
magiche. Le ultime due vittime documentate furono mandate al rogo a
Cairo nel 1630 dopo un processo in cui furono coinvolte 6 donne del
posto. Ecco perché all’epoca del nostro racconto la
memoria è ancora fresca.
 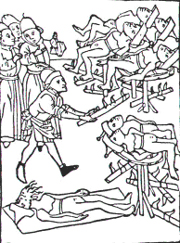
(9)
Contacc = contagio. Questa imprecazione risale al XVI secolo, durante
l’imperversare delle tremende epidemie di peste e di vaiolo.
Citare questa grande disgrazia si pensava potesse avere l’effetto
di scongiurala.
(10) Piemontesismo per indicare birichineria, monelleria, malefatta.
|