I primi a montarlo in battaglia furono gli Sciti, «signori delle steppe».
Quando nelI'VIII secolo si diffuse 'la staffa,’ la cavalleria pesante divenne una protagonista della storia.
Un grande storico francese, Lucien Febvre, se la prendeva spesso con
gli studiosi usi a trattare certi temi di storia socioeconomica senza
preoccuparsi minimamente dell'aspetto tecnico di essi: con quanti a
esempio, conducendo un'indagine di storia dell'agricoltura, mostravano
sovrana nonchalance per tutto quel che concerneva gli attrezzi
agricoli, i metodi di trattamento del terreno, i ritmi e i sistemi di
lavoro. Come se — commentava il Febvre — i contadini d'un
tempo avessero arato la terra con dei pezzi di carta.
Anche la storia cosiddetta «militare», o la storia della
guerra in genere, è stata a lungo vittima di atteggiamenti e di
pregiudizi di questo tipo, e studiata al massi¬mo come un aspetto
collaterale della storia politica e diplomatica: lavoro aulico e
accademico, da farsi a tavolino, lontano dalle cure
«meccaniche». Si parlava così di storia navale senza
saper con esattezza neppure in che modo erano disposti i banchi dei
rematori su una galea; si discuteva d'artiglieria e della sua
importanza nelle guerre napoleoniche senza aver la minima idea di quali
problemi comportasse la fusione d'un cannone. In Italia, un
atteggiamento del genere è stato a lungo sostenuto dall'egemonia
dell'idealismo che tendeva a svalutare gli aspetti
«pratici» delle questioni e a privilegiare invece il legame
tra storia e filosofia. In una storia militare che — a parte i
benemeriti sforzi di molti — era sempre più in
realtà storia di sovrani e di istituzioni, storia di battaglie e
di schieramenti (quando non scadeva nel retorico e nel celebrativo)
capi e soldati venivano costretti, spesso, a combattere con pezzi di
carta, a cavalcare pezzi di carta. Da qui l'immeritato ostracismo di
cui nel nostro Paese la storia militare è stata vittima nel
dopoguerra, aggravato da un equivoco di natura politica: si temeva che,
dopo che il fascismo ne aveva fatto materia di studio nelle scuole, la
storia militare non potesse non essere una disciplina
«militaristica». E ciò, nonostante il lavoro di
ottimi specialisti, quali Piero Pieri e la sua scuola. Oggi, comunque,
tale impasse pare definitivamente superata. Scienze Come l'archeologia,
la storia della tecnologia, la storia delle culture materiali, sono
venute in aiuto allo storico costringendolo — è vero
— a un supplemento di preparazione e alla faticosa disciplina del
lavoro in équipe, ma fornendogli al tempo stesso un decisivo
strumento nella soluzione di problemi per i quali la sua tradizionale
«attrezzatura umanistica» (si parla, beninteso,
dell'Italia) era insufficiente.
Questo rinnovamento metodologico è partito dalla scuola francese
del Febvre e di Mare Bloch e si è ampiamente giovato dei
progressi compiuti, nel campo dello studio delle culture materiali,
specie in Unione Sovietica, in Ungheria, in Polonia. Il nostro Paese,
come purtroppo capita spesso, non è stato neppure in questo caso
all'avanguardia: ma sta almeno imparando, ed è già
qualcosa.
Alla luce di queste nuove esigenze, gli studiosi di storia antica e i
medievalisti sono tornati a esaminare le vicende di un protagonista
dell'età preindustriale: il cavallo, compagno dell'uomo sul
campo di battaglia e nel lavoro.

Per intere generazioni si è ripetuto che il medioevo è
l'età della cavalleria e dei grandi dissodamenti, quindi del
cavallo-arma e del cavallo-forza motrice. Già, è presto
detto: ma, nella realtà concreta, che tipo di cavallo?
Proveniente da dove? Allevato e addestrato come, da chi? Capace di
quali prestazioni? Condizionato da quali limiti? Selezionato secondo
quali principi, e con quali tecniche? Infine, costoso quanto, e dunque
accessibile a quali ceti?
Tutto ciò non basta ancora. Se esaminiamo le antiche fonti
relative al cavallo — da quelle scritte a quelle archeologiche o
monumentali — noi troviamo in esse il costante comune
denominatore mitico-sacrale. Presso i Greci, esso è l'animale
sacro ai luminosi dèi celesti come Apollo non meno che alle
divinità degli abissi marini o sotterranei, a Poseidone e ad
Hades che nell'Iliade compare con l'epiteto di «Signore dei
corsieri». Accompagna e simbolizza l'«apoteosi»,
cioè la divinizzazione dei mortali, degli eroi ellenici come
degli imperatori romani: le statue equestri sono l'espressione di
questo importante quadro sacrale. La morte e la rinascita, la discesa
agli inferi e l'ascesa ai cicli sembrano essere strettamente connesse
al culto del cavallo: Pegaso, il corsiero alato di Bellerofonte, si
dice nato dal sangue di Medusa e nel suo stesso nome (da pegài,
«acque marine») rinvia a una nascita oscura, a un culto
tellurico. Nei miti si può dire di tutti i popoli indoeuropei il
ricordo del sacrificio del cavallo è connesso al culto degli
dèi uranici, ma d'altro canto quell'animale ha un ruolo
fondamentale nelle esequie e accompagna il morto verso la sua estrema
dimora. L'uso dell'inumazione del cavallo insieme al cavaliere era
diffuso tra i Reitervölker («popoli cavalieri») delle
steppe, quelli di stirpe indoeuropea non meno che gli ugriani. Ancora
ai giorni nostri il folklore degli ultimi discendenti degli antichi
Sarmati, cioè degli Osseti del Caucaso, presenta l'ultimo
viaggio del defunto come un'avventurosa cavalcata oppure come un
«rinascere» entro la pelle di un cavallo sacrificato: lo
stesso mito del «cavallo di Troia» sembra ricondurre a
credenze del genere. Le leggende relative a cavalli parlanti e
predicenti il futuro, rimaste nell'epica medievale e nelle fiabe
popolari, risalgono direttamente all'antichità greco-romana non
meno che a quella celto-germanica. Cavalli sacri, dotati di poteri
divinatori, erano venerati presso i Celti e presso i Germani; tra i
Galli era conosciuta la dea Epona, protettrice di stalle e di
cavalieri; nella mitologia germanica, il cavallo era compagno degli
dèi superiori, gli «Asi» (si ricordi soprattutto
Sleipnir, l'ottopode corsiero di Wotan), e delle Walkirie. Nelle
legioni romane acquartierate nell'area danubiana, era diffuso il culto
di una divinità equestre, il misterioso «Cavaliere
trace», mentre nell'Egitto ellenistico-romano si adorava un Horus
equestre che uccideva il coccodrillo-Seth (personificazione delle forze
del male) e che forse ha costituito l'archetipo del culto e della
figura di San Giorgio, assai venerato in area copta e
cristiano-orientale. Parecchi santi cristiani — per esempio
sant'Eligio, maniscalco — hanno a che fare con il cavallo e
paiono essere in realtà cristianizzazione di antiche
divinità pagane. Compagno d'oltretomba, il cavallo estendeva il
suo aspetto di tremenda sacralità fino a presiedere a culti e a
credenze legate ai riti di fine e di rigenerazione del mondo. Gli
indiani gandharva e i loro parenti greci, i centauri, possono celare
nelle pieghe del loro mito il ricordo di un popolo di feroci cavalieri.
Soprattutto sembrano rinviare a certe società segrete che
raffiguravano ritualmente il periodico ritorno al caos e quindi
ponevano le condizioni magiche per la successiva restaurazione
dell'ordine cosmico. Società iniziatiche del genere sembrano
essere state quelle dei cosiddetti «guerrieri-belva»
germanici (gli uomini-lupo, ùlfhedhnar, e gli uomini-orso,
berserkif), caratterizzati da una parentela magico-totemica con le
belve di cui assumevano figura, atteggiamenti e nome. Le origini
profonde dell'araldica medievale sono state forse queste. Questa
presenza del cavallo, alla fine dell'antichità e all'inizio del
medioevo, si sdoppiò caratteristicamente, nella simbologia
cristiana, in due ordini opposti di valori. Da un lato il cavallo
divenne per eccellenza l'animale nobile, il simbolo delle più
rare virtù di coraggio e di lealtà (era il compagno del
cavaliere e di certi santi guerrieri, come Giorgio e Demetrio);
dall'altro era una belva feroce e terribile (i cavalli
dell'Apocalisse), addirittura forma preferita delle incarnazioni
demoniache (i «cavalli neri» della leggenda di Teodorico,
ricordata anche in un celebre passo di Giosuè Carducci, o della
cosiddetta «caccia feroce», apparizione notturna di funesti
cacciatori).
Comunque fosse, la demonizzazione non bastò a far dimenticare ai
popoli da poco evangelizzati che la presenza equina era una presenza
sacrale. I morsi, le briglie, gli speroni, più tardi le staffe,
sepolti accanto ai guerrieri germanici ormai cristiani, sono qualcosa
di più che oggetti onorevoli indicanti la funzione militare e il
rango del defunto: costituiscono forse il segno magico della
persistente presenza del compagno d'oltretomba. Così le fibule
longobarde «a testa di cavallo». Un quadro simbolico e
mentale così ricco e complesso — esso, come ha notato Cari
Gustav Jung, permane nella fantasia onirica, dove il cavallo ha un
ruolo primario (si pensi al famoso dipinto Incubo di Johann Heinrich
Füssli, opera del 1781) — era un corrispettivo
dell'importanza del cavallo nella vita sociale e materiale e nelle
tecnologie militari e produttive degli antichi popoli, soprattutto
degli indoeuropei.
Il suo uso si affermò comunque con relativa lentezza: la fama
che ancor oggi sopravvive della sua «furia», della sua
«pazzia», attesta che l'addomesticarlo non dovette essere
facile. Di recente si è sviluppata tra gli studiosi un'ancor non
risolta polemica sull'animale il cui addomesticamento dovette far da
modello a quello equino, e di cui pertanto il cavallo finì con
il prendere il posto. Prove linguistiche e archeologiche militano a
favore di una sostituzione del cavallo all'onagro (cioè
all'«asino selvaggio») a sud del corrugamento
alpino-himalayano, alla renna a nord di esso.
Si deve ad ogni modo notare che entrambi quegli
animali erano usati come trascinatori di carri piuttosto che come
trasportatori di pesi e di uomini sul dorso. Le testimonianze sumeriche
dell'onagro aggiogato risalgono al III millennio a.C., e il nome
sumerico del cavallo suona «onagro di montagna»,
«onagro d'oriente», con palese
rinvio all'altipiano iranico. Del resto l'ondata dei popoli
indoeuropei nella prima metà del II millennio
dovette perfezionare l'uso del cavallo aggiogato al carro piuttosto che
introdurre l'uso del cavalcare, che richiedeva un lungo addestramento,
un rapporto particolare tra uomo e animale, lo sviluppo della complessa
bardatura da testa e da groppa. I rilievi tebani che illustrano la
guerra tra il faraone Seti I e gli Hittiti (fine del XIV secolo a.C.)
mostrano che questi ultimi usavano per combattere il carro da guerra, e
cavalcavano solo quando si trattava di svolgere funzioni di staffetta o
di esploratore.
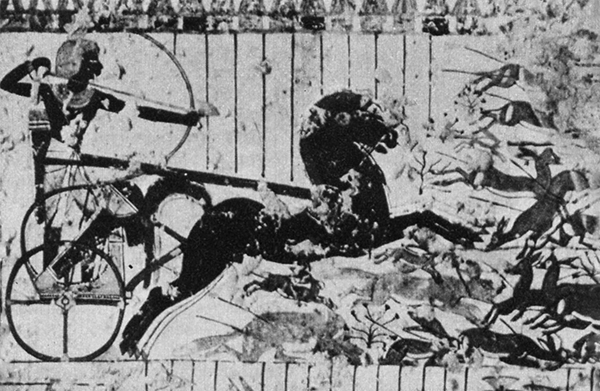
Userhet, segretario del faraone Amenofi II
a caccia di cervi con
l'arco su un carro leggero trainato da un focoso cavallo.
(Affresco dalla tomba di Userhet, a Tebe, sulle rive del Nilo)
Questa sfiducia nelle prestazioni belliche del cavallo
(forse derivata dalla sua ombrosità e dal suo carattere
impulsivo) sopravvisse a lungo. Ancora nell'età altomedievale
alcuni popoli germano-occidentali (gente assuefatta alla foresta e alla
palude, dunque meno familiarizzata con il cavallo di quanto non fossero
le popolazioni germano-orientali come Goti e Longobardi, abituate alla
steppa) cavalcavano sì per spostarsi da un luogo all'altro o per
cacciare — o anche per motivi di prestigio — ma in
battaglia preferivano scendere e combattere a piedi. Quanto al
permanere dell'uso del carro da guerra, i suoi vantaggi sono evidenti:
l'equipaggio di un carro era formato dall'auriga, che pensava solo alla
guida dei cavalli, e dal guerriero che sciolto da quella preoccupazione
poteva dedicare intere le sue energie allo scontro.

Carro ippotrainato con un arciere hittita e il suo auriga.
Scultura dalle mura di Karkemish dell'870 a. Cristo.
Quando si
cominciò a combattere dal dorso del cavallo (furono i popoli
nordiranici, specie gli Sciti, e quelli «delle steppe» a
farlo per primi), ciò avvenne estendendo alla guerra le tecniche
venatorie: i primi guerrieri a cavallo furono armati alla leggera,
erano principalmente arcieri che esercitavano il combattimento da
lontano, in corsa, abili soprattutto nel farsi inseguire tirando poi
sull'inseguitore (la proverbiale «freccia del Parto»). Lo
studioso italiano Augusto Azzaroli ha scorto in un tardo rilievo
hittita, risalente all'VIII-VI secolo a.C., la prima sicura prova
archeologica di un guerriero a cavallo: ma va da sé che l'uso
del carro da guerra rimase vivo a lungo, prima di restringersi alle
parate e ai giochi sportivi. È noto che la cavalleria romana,
armata alla leggera, combatteva usando la tecnica del volteggio e
serviva principalmente per preparare il terreno: essa ebbe sempre un
ruolo ausiliario rispetto alla fanteria pesante delle legioni. Da un
punto di vista militare, comunque, si ha l'impressione che l'importanza
della cavalleria si sia affermata relativamente tardi nella storia,
grosso modo non prima della fine dell'antichità. Questo errore
di prospettiva deriva dalla nostra educazione, storicamente parlando,
«etnocentrica». Quando noi diciamo
«antichità», continuiamo a pensare principalmente a
quella greco-romana, massimo circummediterranea. Ma il mondo
greco-romano — un mondo di colline e di montagne, di paludi, di
boscaglie, di campi coltivati, di porti marittimi — non è
un mondo adatto al cavallo: o almeno, non particolarmente. Il regno
d'elezione di questi è costituito invece dai grandi altipiani e
dalle vaste pianure spazzate dal vento: l'altipiano iranico, il deserto
siro-arabico, il Sahara, e soprattutto quel mare d'erba e di pietre
solcato da grandi fiumi e avente per confini a nord la taigà, ad
est l'Altai e — riprendendo oltre esso — la grande muraglia
cinese, a sud i rilievi caucasico-himalayani, ad ovest la piana del
Danubio e il limes romano. Un mondo di pascoli e di polvere, di nomadi
e di pastori, limitato dai tre grandi imperi antichi, romano, persiano
e cinese: la steppa. Quella era la patria delle culture dei
«popoli cavalieri».

Il nostro discorso sulla cavalleria
medievale si apre dunque con uno sguardo alla cultura scito-siberiana,
fiorita tra il VII e il III secolo in una vasta area, grosso modo
inquadrabile tra il basso bacino del Dniepr, il Caucaso e l'Altai, ma
imparentata strettamente con le culture transaltaiche dei popoli di
stirpe mongoloide da un lato, con quelle nordiraniche stanziate tra
Caspio, Aral, Pamir (Sarmati e Saci) dall'altro. La civiltà
equestre, nei suoi aspetti tecnologici non meno che nelle sue
espressioni magico-religiose (il cavallo è una presenza sacrale
costante nelle tecniche sciamaniche di «viaggio
all'Aldilà»), ha la sua culla nel cuore stepposo del
continente eurasiatico.
Gli Sciti raccolsero, forse tramite l'Urartu (a sud del Caucaso),
l'eredità hittita e la perfezionarono, rimanendo in contatto
lontano, ma diretto, con la grande cultura cinese, come testimonia la
tecnologia della cosiddetta «arte delle steppe». I
progressi di questi popoli nell'equitazione sono evidenti.
Già dalla prima metà del I millennio a.C. il morso da
bocca «snodato» o «articolato» — che
permetteva di dirigere il cavallo senza ferirlo — era diffuso in
tutta l'Asia nord-occidentale, e dal VII secolo è documentato
con certezza nei kurgan (tombe a tumulo) dell'Altai. Intanto,
l'incontro tra le varie razze equine — la bassa, tarchiata razza
mongolica, da cui discendono il «cavallo di Przewal'skij» e
il tarpàn, e l'alta, robusta razza occidentale — avvenuto
probabilmente in area caucasica, favorì ampiamente nel tempo la
selezione. Gli Sciti — come pare testimoniato da una brocca a
rilievo trovata nella necropoli di Certomlyk, sul Dniepr —
usavano in battaglia cavalcare una razza grande e pregiata, simile a
quella di cui si servivano gli hittiti, mentre per altri usi
ricorrevano ai tozzi cavallini della steppa, capaci di fornir buone
prestazioni nella caccia e nei viaggi. Il cavallo
«sarmatico» che i latini chiamavano verèdus doveva
appartenere a questo secondo tipo. Dal tardo latino,
paraverèdus, poi trasformato in parafrèdus si sono
sviluppati i termini palegroi francese, palafreno italiano, Pferd
tedesco, tutti usati per indicare un cavallo da sella ma inadatto a usi
militari. Ben altre origini può vantare il grande cavallo da
battaglia. Per illustrarle, è utile partire da un episodio della
storia cinese della dinastia Han. Nella seconda metà del II
secolo a.C. l'imperatore Wu-ti, preoccupato delle scorrerie degli
Hsiung-Nu, stanziati tra Baikal e Huang-Ho, contro le sue frontiere,
ricorse per tenerli a bada a due accorgimenti. Il primo fu il
rafforzamento della Grande Muraglia; il secondo l'organizzazione di una
cavalleria pesante dotata di lunga lancia, di spada a due mani,
d'armatura di cuoio o di metallo: una cavalleria che non avesse nulla
da temere dal lancio delle frecce. A questo scopo occorrevano grandi e
forti cavalli.
Il piccolo cavallo del tipo Przewal’skij, usato
dalla cavalleria leggera cinese e dai suoi avversari nomadi, era
inadatto a così tanto: aveva taglia modesta, resistenza e
velocità moderate, testa e collo tozzi, zampe corte, garretto
basso.

Cavallo e cavaliere mongoli in un dipinto cinese su seta del XIII secolo.
Tozzo, corto di gambe e di collo, questo quadrupede è l'antico progenitore
del "cavallo di Przewal'skij"
Wu-ti venne a sapere che, nel paese di Ta-yuan, esistevano
«cavalli celesti», nati da divini. Erano imprendibili
stalloni che abitavano sui monti dai quali scendevano per unirsi con le
giumente. Il Ta-yuan corrispondeva al Ferghana, cioè all'area a
nord dell'alto corso del Syr-Daria, là dove giungono i
contrafforti del Tian Chan. Esso era abitato dal popolo indoeuropeo dei
Saka (i Saci), affini agli Sciti.

L'impugnatura di un pettine d'un sovrano scita del IV sec. a.C.
raffigurante un combattimento tra fanti e cavalieri
Tra 102 e 101 a.C., Wu-ti
riuscì a piegare il regno del Ta-yuan e a importare in Cina i
prodigiosi cavalli, i quali dovevano essere del medesimo tipo usato dai
Parti e dai Sarmati, dai popoli cioè che avevano già
sperimentato la cavalleria pesante. Erano animali alti e forti, atti a
sostenere grandi pesi e dure fatiche, poco ombrosi e impressionabili,
inclini ad affiatarsi con l'uomo. L'odierna razza dello Shire è
tipologicamente e caratteriologicamente vicina ad essi.
Fu su queste basi che avvenne, nell'Eurasia del I secolo a.C., una vera
e propria «rivoluzione militare». Diamo la parola, per
illustrarla, a uno storico sovietico, il Gumilev: «A Occidente i
Parti e i Sarmati introdussero l'uso della cavalleria pesante. I corpi
del cavaliere e del cavallo erano coperti di una corazza a scaglie, un
alto elmo a punta proteggeva la testa. Il cavaliere aveva come armi
d'offesa una lunga, pesante lancia e una spada a due mani. I guerrieri
così armati si ordinavano su una linea e travolgevano la folla
degli avversari armati alla leggera. Così i Sarmati ebbero
facilmente ragione degli Sciti nelle steppe del Mar Nero, e i Parti
arrestarono l'avanzata delle legioni romane, respingendole dal Tigri
all'Eufrate». Più tardi, appunto nel secolare scontro con
i Parti, anche i Romani adottarono questo tipo di cavalleria pesante:
«catafratti», ausiliari d'origine sarmatica. L'importanza
del cavallo del tipo del Ferghana, con la sua indole calma e
coraggiosa, era fondamentale per il catafratto. Egli disponeva di
un'alta, pesante sella, un vero e proprio sedile (questo infatti
significa, in latino, il termine sella), dato che la vecchia sella
leggera, o gualdrappa-semisella, non avrebbe consentito comodità
e stabilità a un cavaliere pesantemente armato. Egli era
però una greve massa di muscoli e d'armi in equilibrio su un
alto animale: il tipico punto di appoggio e di forza dell'uomo a
cavallo, la staffa, gli mancava. Tuttavia pare che la sua statica fosse
eccellente. Si suppone che egli disponesse di un sistema di fissaggio
al cavallo della lunga lancia che doveva manovrare a due mani, sistema
che consisteva in supporti e corregge; e che appoggiasse la parte
inferiore delle cosce e del bacino alle due faretre disposte ai due
lati posteriori della sella. Inoltre il sistema di cavalcare differiva
da quello successivo: il cavaliere premeva cosce e gambe lungo i
fianchi e la pancia dell'animale, con le ginocchia leggermente
divaricate, in modo da accrescere la solidarietà statica del suo
corpo con quello del cavallo; per serrare meglio la cavalcatura,
disponeva poi le gambe in una posa asimmetrica. Nell'impatto con la
lancia, compensava lo squilibrio del contraccolpo torcendo il busto e
piegando in avanti la spalla destra in modo da recuperare un sicuro
baricentro.

Cavallo e cavaliere germanici da un monumento sepolcrale di Hornhausen (700 a.C.)
Si deve notare che il maneggio della lancia a due mani impediva di
governare le redini durante la carica: il che presuppone un animale
talmente docile e affiatato con il suo signore da poter essere guidato
solo dalla voce e dalla pressione delle gambe. Ciò significa
lungo tirocinio; significa vita comune, amicizia,
«fratellanza» tra cavallo e cavaliere. Del resto, quando
parliamo di attrezzatura del cavaliere pesante noi ragioniamo troppo da
occidentali moderni: diamo cioè spazio eccessivo alla tecnica
materiale, sottovalutando l'addestramento. Non doveva trattarsi solo di
un certo tipo di morso o di sella: non a caso tutti gli antichi teorici
dell'equitazione, da Senofonte in poi, insistono sull'addestramento e
l'esperienza. Le prestazioni per esempio degli odierni cavalieri
afghani — o quelle dei nostri acrobati equestri «d'alta
scuola» — ci stupiscono ancor oggi anche perché
vengono effettuate quasi senza l'aiuto di strumenti. Quando noi diciamo
che questa o quella cosa era impossibile senza la staffa, mentre le
fonti ci provano il contrario, è evidente non che le fonti
sbagliano, ma che a noi sta sfuggendo qualcosa. E si torna,
così, dalla storia della tecnica a quella della
mentalità: si torna alla sepoltura comune del guerriero e del
cavallo; si torna a quella sorta di identità fra uomo e animale
che pare adombrata nel mito del centauro e che le leggi alemanne, in
età altomedievale, chiamavano in causa affermando che colpire il
cavallo era come colpire il cavaliere. Al cavallo il guerriero parla; a
lui si rivolge chiamandolo per nome; ed esso è talmente fedele
al suo signore — da Decio Mure al Cid Campeador — da
seguirlo fino alla morte, sacrificandosi con lui e per lui. Il cavallo
da guerra medievale è ancora, e resterà per il cavaliere,
l'arcano compagno dei kurgan della steppa e dei sepolcri
germanici, il fratello-guida dell'oltretomba, il veicolo della morte e
della gloria. Nell'Occidente altomedievale la tradizione del cavaliere
catafratto decadde e tese a scomparire con la decadenza dell'impero
romano, anche se pare che Goti e Longobardi ne perpetuassero le
tecniche. La cavalleria pesante si riaffermò comunque di nuovo a
partire dalla seconda metà dell' VIII secolo, con l'arrivo di un
nuovo strumento, la staffa. Essa pare sia nata verso il II secolo a.C.
in India, ma la sua data di nascita e la sua evoluzione continuano a
essere oggetto di controversia. Nella sua definitiva struttura —
cioè come un triangolo ligneo o metallico, evoluzione forse di
un primitivo laccio di cuoio — sembra essersi definitivamente
affermata in Cina e nelle culture centroeurasiatiche solo a partire dal
V secolo. La sua primitiva e fondamentale funzione dovette esser quella
di consentire una comoda ascesa in sella. Essa tuttavia forniva in
realtà prestazioni che sembrano più importanti:
conferendo al cavaliere maggiore stabilità, gli permetteva una
libertà prima sconosciuta nei movimenti (per esempio nel tirar
d'arco); offrendo un solido punto d'appoggio creava una nuova
solidarietà statica uomo-cavallo e consentiva lo sviluppo di un
nuovo maneggio della lancia, quello che sarebbe divenuto caratteristico
del cavaliere medievale, cioè l'attacco «a fondo»
condotto imbracciando la lancia e serrando l'asta sotto l'ascella.
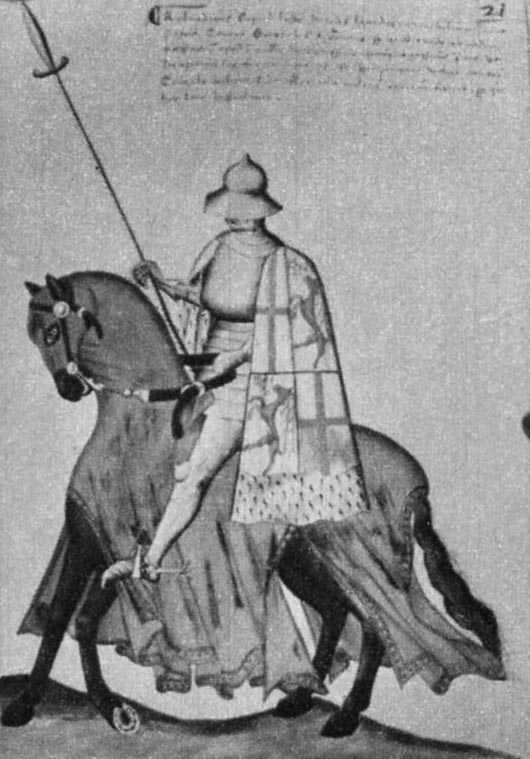
Lanciere medievale a cavallo in una miniatura da un antico codice ferrarese.
Si
è obiettato che, in realtà, il nuovo maneggio della
lancia si ebbe solo a partire da qualche secolo più tardi
rispetto all'arrivo della staffa in Occidente; tuttavia, non si deve
dimenticare che il nuovo strumento, consentendo al cavaliere di alzarsi
in piedi facendo forza sulle staffe, gli permise un nuovo e micidiale
uso della lunga spada caratteristica dei Reitervölker, spada che
sarebbe diventata l'emblema del cavaliere medievale. Il colpo vibrato
con la lunga, pesante arma da fendenti — così diversa dal
corto gladius romano, un'arma che si usava di punta — era
micidiale se calava dal braccio di un cavaliere. La spada difatti
poteva acquistar forza descrivendo un arco di quasi centottanta gradi.
Va da sé che l'adozione della spada da fendenti imponeva la
risoluzione di grossi problemi di tecnica metallurgica. In tal modo
sviluppo dell'equitazione e sviluppo della siderurgia s'integravano a
vicenda.
Affermatasi in Persia e a Bisanzio verso il VII secolo, la staffa
passò in Occidente tramite i Bizantini (fra l'altro, molti
guerrieri germanici solevano recarsi a Costantinopoli per servirvi come
mercenari), ma forse anche grazie all'esempio dei nomadi Avari. Nel
corso del IX secolo, la cavalleria europea prese a disporre anche del
ferro, che riduceva le possibilità di scivolata del cavallo e di
rottura dello zoccolo. Una serie di coincidenze e una discreta dose di
determinismo hanno fatto sì che in un recente passato si sia
attribuita alla staffa un'importanza forse eccessiva nel mutamento
delle strutture sociopolitiche dell'Alto Medioevo e nella nascita della
società feudocavalleresca. Si notò che lo sviluppo della
cavalleria pesante legato alla concessione, da parte sovrana, di una
quantità di beni (terre, di solito) sufficiente a chi la riceve
per mantenersi ben armato, data appunto dalla metà dell'VIII
secolo, e vi si volle vedere una risposta ai raid al di qua dei Pirenei
degli Arabi di Spagna.
Le cose stanno in modo sensibilmente differente. È un fatto
semmai che nella Francia dell'VIII secolo — a parte il pericolo
costituito dai raid arabi e da quelli avari — si
verificò una sorta di colpo di Stato che abbatté la
vecchia dinastia merovingia e instaurò quella carolingia. I
nuovi padroni, consci della loro illegittima posizione, provvidero a
corroborarla concedendo ai loro sostenitori terre in misura tale che
permettessero loro di armarsi in modo superiore alla restante
popolazione franca. Con ciò, essi avviarono un processo
verificatosi in tutto il continente, che consisteva nel dicotomizzarsi
delle società germaniche (originariamente costituite da liberi
guerrieri, e liberi in quanto guerrieri) in una élite di
possidenti che grazie alle loro ricchezze potevano specializzarsi
nella guerra — i milìtes — e in una massa di
contadini che l'alto costo dell'equipaggiamento militare costringeva a
rinunziare all'uso delle armi e a fornire, in sostituzione, il frutto
del loro lavoro — i rustici—. In questa divisione del
lavoro e in questa gerarchizzazione del prestigio sociale sta il nucleo
della civiltà feudocavalleresca, che avrebbe dominato la scena
europea fino all'età delle crociate. Non si diventava, quindi,
milites per diritto di nascita (non nei primi tempi né solo per
quello, almeno): lo si diveniva per abilità guerriera e per
disponibilità di beni economici. Un cavallo in realtà
costava molto, e le varie armi pesanti di offesa e di difesa non erano
da meno. Una fonte, grosso modo coeva a Carlo Magno valuta un cavallo
dalle 3 alle 6 volte più di un bue. Il cavallo divenne da allora
veramente un protagonista privilegiato della storia.

Due aurighi romani da circo con i cavalli riccamente imbrigliati.
(Mosaici conservati al Museo Nazionale di Roma)
Per lui si
dovettero modificare anche abitudini e tecnologie agricole.
Poiché esso aveva bisogno di avena, di orzo, di foraggio, i
mercati dovettero adeguarsi alla domanda di questi prodotti. Il
tradizionale «campo di marzo», l'assemblea armata degli
antichi Germani, si mutò dall'età carolingia in
«campo di maggio», in modo da permettere ai cavalli di
trovare foraggio fresco in abbondanza. Il fatto che il cavallo fosse
sempre più apprezzato come animale da guerra non significa che
scomparisse come bestia da lavoro. Semmai, ebbe grande sviluppo la
selezione delle razze equine. A partire dal X secolo si sviluppò
l'allevamento di una razza alpino-occidentale forte e di massicce
strutture, adatta al pesante carico del cavaliere armato non meno che
alla greve charrue, l'aratro continentale adatto ai terreni pesanti del
Nord. Ma per quanto, al settentrione soprattutto, restasse impiegato
nell'agricoltura, il cavallo era ormai avviato a presentarsi sempre
più come un animale da guerra: anzi — nella realtà
e nelle rappresentazioni collettive — come l'animale da guerra
per eccellenza. Lo sarebbe rimasto fino alla soglia dei giorni nostri.
I bambini che ancor oggi restano affascinati dinanzi ai grandi cavalli
bianchi delle giostre obbediscono, senza saperlo, a un'antica
suggestione, aderiscono a un linguaggio collettivo antico di millenni.
Sono in realtà, anch'essi, molto più figli della steppa
di quanto non suppongano nei loro giochi guerrieri.

San Giorgio, sul suo cavallo bianco, uccide il drago.
(Icona russa del XV secolo, Mosca, Galleria Tretjakov).